Il testamento biologico in Italia: tra diritto all’autodeterminazione e applicazione ancora parziale
- Dott.ssa Alessia Perrone
- 17 nov 2025
- Tempo di lettura: 3 min

Il cosiddetto “testamento biologico” — più correttamente definito «disposizioni anticipate di trattamento» (DAT) — rappresenta una delle conquiste recenti del diritto alla salute in Italia, ponendo al centro la volontà del paziente nel momento in cui non sia più in grado di esprimerla autonomamente. Con la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, il legislatore ha voluto garantire che «nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata». Inoltre, all’articolo 4 della legge è prevista la possibilità per ogni maggiorenne capace di intendere e volere di esprimere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, le proprie volontà riguardo agli accertamenti diagnostici, alle scelte terapeutiche e ai singoli trattamenti sanitari. Con questo strumento si riconosce il diritto all’autodeterminazione in tema di salute — diritto già presente nella Costituzione (artt. 2, 13, 32) — e si afferma il principio secondo cui la persona può scegliere in anticipo le modalità delle cure da ricevere o rifiutare in situazioni di grave malattia o incapacità.
Dal punto di vista operativo, il paziente può redigere le DAT in forma scritta con l’assistenza del medico, e può indicare anche un fiduciario che lo rappresenti nella relazione con l’equipe sanitaria nel caso in cui egli non possa più comunicare. Le DAT sono registrate in una banca dati nazionale predisposta dal Ministero della Salute, che consente ai Comuni, ai notai e alle strutture sanitarie di trasmettere le volontà espresse. (Ministero della Salute)
Nonostante la legge sia entrata in vigore da diversi anni, la sua applicazione presenta ancora lacune significative. Le statistiche più recenti rilevano che, al 31 dicembre 2023, risultano depositate circa 230.940 DAT in 6.096 Comuni italiani, cioè una DAT ogni 191 maggiorenni. Tuttavia, queste cifre mostrano una copertura molto limitata rispetto al potenziale bacino di utenti. Inoltre, molte associazioni segnalano l’assenza di una vera e propria campagna informativa istituzionale: una recente indagine rileva che circa il 75 % degli italiani ritiene che le istituzioni non abbiano informato adeguatamente sulla possibilità di redigere le DAT. Un altro aspetto problematico è la mancata piena attuazione delle modalità di deposito presso le strutture sanitarie o la registrazione nella banca dati: in molti casi i Comuni non hanno trasmesso i dati, o le strutture sanitarie non hanno ancora previsto procedure operative.
Dal punto di vista etico, lo strumento delle DAT balza al centro del dibattito sul “fine vita”. Da un lato pone l’accento sulla dignità della persona, sulla libertà di scegliere se e come essere curato – o non curato – in condizioni di grave compromissione. Dall’altro, solleva questioni operative e deontologiche: la capacità del medico di rispettare la volontà del paziente, il ruolo del fiduciario, la distinzione tra trattamenti sanitari ordinari e “accanimento terapeutico”, il monitoraggio delle DAT depositate e consultabili. La legge lo stesso prevede che l’equipe sanitaria deve valutare se un trattamento sia sproporzionato rispetto ai benefici attesi, e, nel rispetto della volontà del paziente, decidere di sospenderlo. Va sottolineato che le DAT non equiparano l’eutanasia o il suicidio assistito: il paziente esprime volontà di trattamento o rifiuto nel momento in cui ancora è capace, ma non si tratta di chiedere al medico di provocare la morte. È differente, per il nostro ordinamento, il percorso giuridico che regola l’aiuto al suicidio o l’eutanasia.
In sintesi, lo strumento del testamento biologico in Italia è ormai una realtà normativa, ma la sua efficacia concreta è ancora limitata da un’informazione insufficiente, da procedure operative non uniformate e dalla complessità etica e organizzativa che accompagna le decisioni sul fine vita. Per potenziare realmente l’autodeterminazione del paziente appare necessario non solo semplificare l’accesso e il deposito delle DAT, ma anche promuovere una cultura della comunicazione medico-paziente, attivare campagne pubbliche di informazione, e garantire che le strutture sanitarie siano pienamente adeguate a recepire e rispettare le scelte espresse. In questo modo si potrà trasformare un diritto formale già riconosciuto in un’operatività sostanziale, in linea con i principi di dignità, salute e libertà individuale.
Bibliografia / Sitografia
• “https://notaiotorroni.it/wp-content/uploads/2024/10/IL-TESTAMENTO-BIOLOGICO.pdf (notaiotorroni.it)
Articolo a cura della Dott.ssa Alessia Perrone,
Laureata in Servizio Sociale e Politiche e Management per il Welfare.



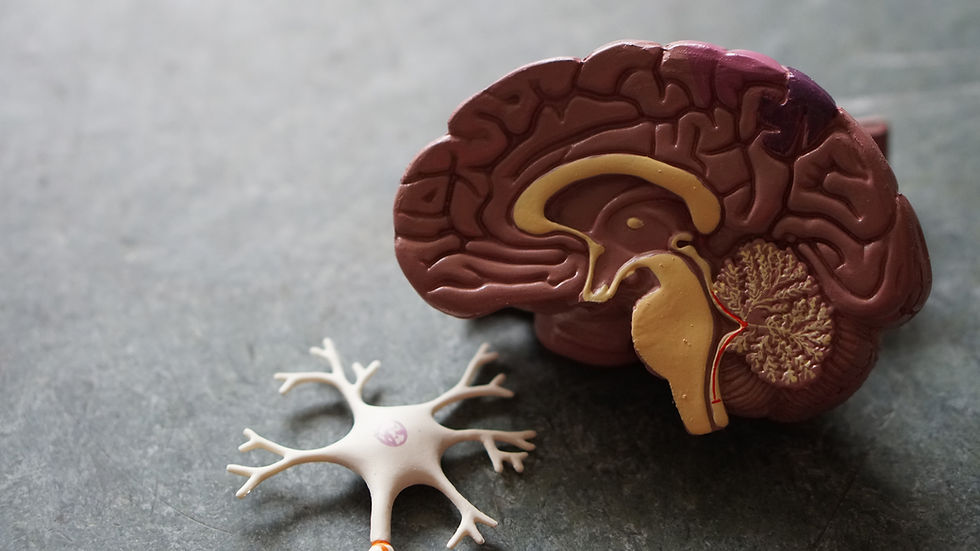
Commenti